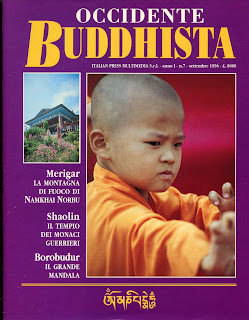Nel n. 2 del 1991 comparve sulla rivista Micromega una serie di testi relativi ad una polemica, risalente al periodo 1938-40, intercorsa tra M.K. Gandhi e due pensatori ebrei, Martin Buber e Judah L. Magnes. Oggetto della querelle erano le opinioni espresse da Gandhi in un suo articolo del 1938 in merito alle rivendicazioni degli Ebrei sulla Palestina e ai metodi con i quali gli Ebrei stessi, in Europa, avrebbero dovuto secondo lui opporsi alle persecuzioni dei Nazisti.
Si tratta di una polemica assolutamente attuale, benchè risalente ad anni apparentemente lontani. Essa riguarda infatti il tema dell'antisemitismo, purtroppo mai superato. E lo riguarda non solo in generale, ma anche all'interno del pensiero di Gandhi, fino a farci chiedere se in lui, il maestro della tolleranza, non sussistessero tuttavia semi molto sottili di un antisemitismo strisciante, dovuti magari ad una insufficiente conoscenza di ciò che stava accadendo in Europa e/o alle influenze di alcuni aspetti della cultura europea con cui era venuto in contatto durante i suoi studi in Inghilterra (per esempio l'antisemitismo di matrice cristiana).
Si noti al riguardo che l'articolo in questione ("Gli ebrei") fu scritto da Gandhi il 20 novembre 1938, 10 giorni dopo la "Notte dei cristalli", che vide in Germania, Austria e Cecoslovacchia la distruzione di oltre 200 sinagoghe e di 7500 negozi appartenenti ad Ebrei, e la deportazione nei campi di concentramento di almeno 30000 Ebrei. Il tutto due mesi dopo gli accordi di Monaco tra Francia, Inghilterra, Italia e Germania, e quasi un anno prima del patto di non-aggressione tra Hitler e Stalin!
Qui di seguito si può leggere l'ottimo saggio introduttivo di Marco Vigevani, che presenta i testi di Gandhi, Buber e Magnes comparsi su Micromega.
La "doppia morale" del Mahatma
di Marco Vigevani
1. Il 26 novembre
1938, esattamente due settimane dopo la «Notte dei cristalli», il giornale Harijan
(letteralmente, «figli di Dio», il nome coniato da
Gandhi per gli intoccabili), organo del movimento non-violento, pubblica un
intervento del Mahatma dal titolo «Gli ebrei», scritto sei giorni avanti, il 20
novembre. In esso Gandhi affronta due distinte questioni: il conflitto
arabo-ebraico in Palestina e la persecuzione degli ebrei in Germania ad opera
del nazismo. Poiché l'argomentazione gandhiana, per quanto lineare, è
tutt'altro che sistematica (né muterà sotto questo aspetto nei successivi
interventi, fino all'ottobre del '40) è forse utile riassumerne schematicamente
il contenuto.
2. A una iniziale
dichiarazione di simpatia per gli ebrei, che definisce «gli intoccabili del
cristianesimo», per la cui persecuzione i cristiani «hanno fatto appello alla
dottrina religiosa» esattamente come gli indù per giustificare quella dei
fuoricasta, segue una decisa presa di posizione sul problema palestinese.
«L'invocazione di
una nazione per gli ebrei — dice Gandhi — non mi trova particolarmente
sensibile». Né «il richiamo alla Bibbia», né la «tenacia con cui gli ebrei
hanno desiderato il ritorno in Palestina» possono fondare la pretesa ad una
nazione in una terra che «appartiene agli arabi nello stesso senso in cui
l'Inghilterra appartiene agli inglesi o la Francia ai francesi». Non solo gli
ebrei non hanno diritti sulla Palestina, giacché possiedono già altre patrie in
cui lottare per l'uguaglianza e non possono pretendere di avere «una doppia
patria in cui possono rimanere a loro piacere» (e la Palestina biblica «non è
un'estensione geografica... ma è nei loro cuori»), ma anche se pensassero di
averli, «sarebbe sbagliato penetrarvi protetti dall'artiglieria britannica. Non
è possibile compiere un'azione religiosa con l'aiuto delle baionette e delle
bombe». L'unica via per gli ebrei in Palestina è convertire il cuore degli
arabi attraverso la non-violenza, spinta fino a «sacrificarsi e essere uccisi o
gettati nel Mar Morto senza alzare un mignolo contro di essi».
Gandhi non approva
gli «eccessi» degli arabi e vorrebbe che anch 'essi scegliessero la via della
non-violenza, ma, conclude, «stando ai canoni comuni di ciò che è giusto e
sbagliato, nulla può essere detto contro la resistenza araba...».
3. «La persecuzione
tedesca degli ebrei sembra non avere paragoni nella storia», esordisce Gandhi.
«Se mai potesse esistere una guerra giustificabile nel nome dell'umanità (...)
una guerra contro la Germania per prevenire la perversa persecuzione di
un'intera razza sarebbe totalmente giustificata. Ma io non credo in nessuna
guerra.» Se guerra non vi può essere, la via da indicare agli ebrei (Gandhi usa
un termine forte, «prescription») è quella
del satyagraha e dell'ahimsa; la
«forza dell'animo» o della verità e la «non-violenza», ovvero in termini
pratici la non-cooperazione attiva non-violenta messa
in pratica da Gandhi stesso. Per questa via gli ebrei, fidando «in un Dio più
personale del Dio dei cristiani, dei musulmani, o degli indù», giungerebbero a
sciogliere il cuore di Hitler e dei tedeschi. Ma anche ove non vi riuscissero
in tempo utile alla loro personale salvezza, la sofferenza subita
volontariamente susciterebbe in loro gioia e forza interiore e anche un totale
massacro «potrebbe essere trasformato in un giorno di ringraziamento a Jehovah!».
La prova che la non-violenza è applicabile al caso degli ebrei tedeschi è
trovata da Gandhi nell'«esatto parallelo» con la campagna da lui condotta in
Sud Africa per i diritti civili degli indiani. Anche il governo di Kruger era
razzista, anche gli indiani erano pochi (ancor meno degli ebrei in Germania), e
ad essi, a differenza che agli ebrei, mancò del tutto l'appoggio dell'opinione
pubblica mondiale. Se gli indiani hanno vinto con la non-violenza, conclude
Gandhi, a maggior ragione possono vincere gli ebrei.
4. L'intervento di
Gandhi, su alcuni punti del quale varrà la pena ritornare più, avanti, suscita
vivaci proteste e innesca una discussione, che tuttavia, fino al maggio del '39,
ci è possibile seguire solo sulle pagine di Harijan:
ciò comporta che le obiezioni dei critici di Gandhi ci
sono note, fino a quella data, solo attraverso gli stralci riportati dal
Mahatma stesso. Una prima «Risposta ai critici tedeschi» del dicembre '38 ci
informa delle proteste suscitate tra i tedeschi non-ebrei, ma non aggiunge
nulla di nuovo all'argomentazione.
Un secondo
articolo, sullo stesso numero di Harijan («Risposta
ad alcune domande»), dà invece a Gandhi l'occasione per affrontare un punto che
ritornerà costantemente nella polemica: se gli ebrei siano o non siano
genuinamente non-violenti. Il leader indiano lo nega, affermando che «gli ebrei
non hanno mai praticato la non-violenza come atto di fede, e tantomeno come
politica calcolata. Tanto è vero che è considerato un marchio per essi che i
loro avi abbiano crocefisso Gesù». Gli ebrei inoltre credono nella legge del
taglione e la loro nonviolenza lungi dall'essere quella gandhiana «è quella
del miserabile e del debole». Punto di vista ribadito nel successivo resoconto
di un dibattito con missionari cristiani (Harijan,
novembre '38): «È vero che gli ebrei non sono stati
attivamente violenti di persona, ma essi hanno invocato la maledizione dell'umanità
sui tedeschi, e volevano che l'America e l'Inghilterra combattessero contro la
Germania a nome loro». L'affermazione viene ripetuta nel febbraio del '39 in un
articolo su Harijan dal
titolo «Nessuna scusa», per essere infine onestamente ritrattata, per mancanza
di prove, nel maggio dello stesso anno. Anche i cinesi non sono non-violenti,
dice Gandhi nel citato articolo del novembre '38, riferendosi alla loro
resistenza contro l'invasione giapponese in corso. Ma, siccome non hanno mire
su altri popoli, egli augura «successo ai cinesi», il cui comportamento (benché
violento) è come per gli arabi «rigorosamente corretto (...) stando ai canoni
comuni (...)».
5. Il
primo critico di parte ebraica citato per nome da Gandhi è Hayim Greenberg,
direttore del periodico newyorkese Jewish Frontier, la
cui replica è significativamente intitolata «Siamo trattati come esseri
inferiori; ci si chiede di essere dei superuomini». Gandhi gli risponde nel
maggio '39.
Di fronte all'obiezione che «un Gandhi ebreo in Germania (...)
potrebbe agire per circa cinque minuti e poi sarebbe prontamente portato alla
ghigliottina (sic)», ribadisce la fede religiosa nella non-violenza, al di là
della sua efficacia o applicabilità in casi concreti, e respinge con sdegno
l'accusa di essersi lasciato influenzare, sulla questione palestinese, dal
desiderio di compiacere i musulmani indiani. Nell'aprile del '39 esce a
Gerusalemme, in inglese, un pamphlet del gruppo «The Bond» («Ha-ol»), fondato
dal rabbino liberale e pacifista Judah L. Magnes. Contiene due lettere a
Gandhi, una dello stesso Magnes e la seconda di Martin Buber. Buber e Magnes
sono entrambi personalità dominanti di un sionismo a-statuale, ed entrambi, ma
particolarmente Magnes — pacifista nella prima guerra mondiale e quasi un
seguace ebreo della non-violenza — tra gli ebrei da sempre più vicini al
pensiero di Gandhi. Con i loro interventi la polemica sale decisamente di tono
e si allarga a una discussione dei caposaldi dell'ebraismo e del sionismo che,
se pure esula in parte dall'occasione che l'ha provocata, rappresenta (in
entrambi i saggi) una delle più felici e importanti esposizioni del pensiero
ebraico moderno. Non risulta, sfortunatamente, che Gandhi abbia mai preso nota
di queste due «lettere» a lui indirizzate, ma ciononostante è attraverso di
esse che tenteremo di cogliere il significato di tutta questa lunga polemica.
6. Sul problema palestinese Buber e
Magnes convergono nella sostanza delle loro obiezioni a Gandhi, tanto che le
loro argomentazioni possono essere ridotte a una sola; cosa che non può
stupire, appartenendo entrambi alla stessa corrente del sionismo.
A) Il richiamo alla Bibbia e la tenacia del
desiderio ebraico di ritornare in Palestina (ai quali Gandhi si dichiara «non
particolarmente sensibile») vanno intesi all'interno del particolare destino
ebraico, espresso nella triade fede-popolo-terra. La fede non è realizzabile se
non nel popolo, e il popolo non può esistere se non sulla Terra. La Terra
d'Israele non è degli ebrei automaticamente in quanto promessa dalla Bibbia,
ma anzi gli ebrei sono della Terra Santa solo in quanto la sappiano servire e
divenire santi anch'essi, senza escluderne perciò altri dal possesso. D'altro
canto, la Palestina della Bibbia non è solo nei cuori, come l'India per Gandhi
non è solo il suolo indiano mala saggezza e la «sostanza» dell'India.
B) La Palestina non appartiene agli arabi nello
stesso senso in cui l'Inghilterra appartiene agli inglesi. Vi sono tre sensi in
cui una terra può appartenere a un popolo: per conquista (Buber e Magnes); per
uso (Buber); per cultura. Nel primo senso, sia gli ebrei che gli arabi, in
epoche successive, l'hanno conquistata e né gli uni né gli altri sono gli
ultimi (ergo legittimi)
conquistatori, che sono invece i turchi e gli inglesi. Ma anche se gli arabi fossero
gli ultimi conquistatori, quale autorità divina stabilisce che la conquista
violenta di una terra debba durare in eterno? Nel secondo senso la terra è di
chi la sa servire e far fruttare, sia esso arabo o ebreo: allo stato attuale
più dei coloni ebrei dunque che dei fellah arabi.
Infine, nel terzo, la Palestina appartiene alle tre grandi religioni in misura
almeno uguale.
C) La doppia patria. Così risponde Buber rivolto
a Gandhi: «Ha forse detto anche agli indiani in Sud Africa che se l'India è la
loro patria, devono abituarsi all'idea che saranno costretti a tornare in
India? 0 ha forse detto loro che l'India non è la loro patria?».
D)
Gandhi accusagli ebrei di voler creare una
nazione con le sanzioni e le armi dell'imperialismo britannico. La
colonizzazione ebraica precede di 35 anni l'inizio del mandato inglese (Buber).
Quanto alle armi inglesi Buber si differenzia dalla non-violenza: «Siamo
convinti [gli ebrei] che l'uomo debba a volte usare la forza per salvare se
stesso e, ancor di più, i suoi figli». E in un altro passo Magnes conferma il
suo dubbio: «Gli ebrei sono un popolo che esalta la vita e diffìcilmente si può
dire che disprezzi la morte. Per questa ragione mi sono spesso chiesto se noi
siamo dei soggetti adatti per il satyagraha».
E) L'appello gandhiano alla non-violenza per
convertire il cuore degli arabi viene affrontato con gli argomenti appena
citati, a cui si aggiunge il rimprovero per non aver rivolto lo stesso monito
agli arabi e anzi aver concesso loro le attenuanti dei «canoni comuni di
comportamento» (diversi da quelli non-violenti).
7. Sulla condotta
consigliata agli ebrei di fronte ai nazisti, Magnes diverge maggiormente da
Buber, in quanto forse si sente più vicino agli insegnamenti del Mahatma e la
sua lettera accorata merita di essere lasciata parlare da sé. Volendo, per
concludere, dare un 'idea sommaria delle articolate argomentazioni che il
lettore potrà trovare più oltre nelle parole di Buber e Magnes, esse si possono
ridurre ad alcuni assunti.
A) Non c'è alcun parallelo possibile tra gli
indiani del Sud Africa alla fine dell'Ottocento e gli ebrei nella Germania
nazista.
B) La campagna non-violenta che assume valore di
testimonianza in un regime libero, o di semi libertà della pubblica opinione,
non ha alcun valore politico in uno Stato totalitario. Al massimo ha un valore
religioso personale e in questo caso la richiesta imperiosa della santità non è
tale da poter essere fatta a un popolo intero. Singoli, numerosi ebrei hanno
già offerto la loro inutile ed eroica «testimonianza» di fronte ai nazisti e
sono morti per questo.
C) Anche Magnes, da pacifista, è convinto che
ogni guerra sia male, persino quella contro la Germania nazista.
Ma tra il male della vittoria
nazista e il male della guerra contro Hitler, che cosa deve scegliere un
pacifista? Ovvero: può non scegliere?
Ma, al di là delle critiche puntuali
alle singole tesi gandhiane, si avverte chiaramente in Buber e in Magnes la
delusione e l'irritazione per il tono usato dal Mahatma. Buber lamenta che
«insieme a quella del buon consiglio e del conforto» si faccia sentire nella
lettera di Gandhi «una terza voce che le soffoca entrambe, quella del
rimprovero». E ancora, sempre Buber: «Lei, Mahatma Gandhi, (...) non dovrebbe
unirsi a coloro che considerano la nostra causa senza comprensione o umanità».
Per Magnes, più vicino a Gandhi per i motivi cui abbiamo accennato, la
delusione è ancora più profonda: «La sua dichiarazione è una sfida,
specialmente per quelli tra noi che si sono considerati
suoi discepoli».
In effetti, anche il lettore odierno
non riesce a sottrarsi all'impressione che dietro la dichiarata equanimità del
Mahatma ci sia, se non un 'ostilità, una grave inopportunità nella «lezione»
che si sente in dovere di impartire agli ebrei vittime del nazismo. Non
dimentichiamo che la lettera di Gandhi è scritta, a caldo, pochi giorni dopo il
primo, grande pogrom antiebraico
nazista: eppure il primo tema sollevato da Gandhi non è quello della
persecuzione nazista, bensì quello della Palestina!
Anche in seguito, i richiami alla
crocefissione di Gesù e alla legge del taglione, sono, oltre che rivelatori di
un antigiudaismo di marca cristiana (che non stupisce troppo in Gandhi, che
considerò sempre Cristo uno dei suoi maestri e il Discorso della Montagna uno
dei suoi testi spirituali), altamente inopportuni, se non decisamente offensivi
nel contesto in cui sono scritti. Solo di sfuggita, Gandhi noterà che «gli
ebrei non sono angeli», senza però mai riconoscere loro quei «canoni comuni» di
comportamento in virtù dei quali salva invece le violenze degli arabi e dei
cinesi, e anzi parzialmente le giustifica. La «doppia morale», la concezione
degli ebrei perfetti o reprobi, tipica della visione teologica cristiana,
appare così essere passata intatta nella visione del mondo del maestro indiano.
8. La polemica che abbiamo
tentato di riassumere e che qui di seguito presentiamo per intero è tale, per
i suoi protagonisti e per i princìpi che coinvolge, da andare oltre il pur
cruciale evento storico che ne fu la causa. Di Gandhi mette in luce, come in
poche altre occasioni, il contrasto tra il santo (il guru) e l'uomo (anche
politico); del suo pensiero evidenzia la sublime grandezza (e per alcuni
l'accento potrà cadere, negativamente anche, su «sublime») e al tempo stesso
l'incompatibilità con la tradizione ebraica e attraverso di essa con una parte
importante della cultura occidentale. È evidente, infine, nel 1991, l'attualità
per la riflessione di oggi di una discussione che ebbe luogo più di mezzo
secolo fa.
#####
Marco Vigevani conclude il suo breve saggio osservando come, nel 1991, anno del suo scritto, le riflessioni sull'antisemitismo e sulla non-violenza siano ancora attuali.
E' passato un altro quarto di secolo, ma l'attualità del tema non è minimamente venuta meno, anzi. La sicurezza del popolo ebraico non è affatto un dato acquisito per sempre, nè in Israele nè in Europa nè altrove. E l'antisemitismo non è stato per nulla cancellato dalle menti e dalle azioni umane. Affiora sempre più sovente, anche nelle sue forme più subdole, spesso nel silenzio dei media (indolenza? complicità? sottovalutazione?). Un solo esempio, marginale fin quanto si vuole, ma si sa, spesso il diavolo si nasconde nei dettagli: moltissimi, dopo i fatti di Parigi del 7 gennaio, hanno (giustamente) scritto ovunque "Je suis Charlie". Ma quanti, in Italia, hanno anche scritto "Je suis Juif"? Eppure, quattro persone, poche ore dopo, nella stessa Parigi, erano state uccise nell'Iper Cacher di Vincennes. Ma tant'è...
Gli scritti di Gandhi sulla "questione ebraica" e sulla resistenza non-violenta al Nazismo sono riportati anche nel volume:
M.K. Gandhi, Teoria e pratica della non violenza, Ed. Einaudi