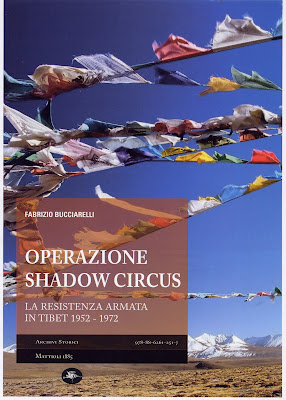Il blockbuster del Dharma: Bernardo Bertolucci e “Piccolo Buddha”
Non so se qualcuno potrebbe affermare
che l’Occidente ha bisogno
di un film come Little Buddha.
(Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama)
Non so se qualcuno potrebbe affermare
che l’Occidente ha bisogno
di un film come Little Buddha.
(Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama)
1916. Nell’ultima scena de “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello il protagonista, lo scrivano Ciampa, la cui situazione di marito “becco” è divenuta di pubblico dominio, sfoga la sua amarezza: “…che cosa debbo fare? Tenermi questo sfregio? Comperarmi una testiera con 2 bei pennacchi, per fare la mia comparsa in paese? E tutti i ragazzini dietro, in baldoria, a gridarmi: Bèèè…Bèèè…”.
1993. “Piccolo Buddha”, il famoso film di Bernardo Bertolucci, inizia con la sequenza di un giovane monaco che, alla richiesta di Lama Norbu di “mostrare qualcosa della sua vita precedente”, si mette a belare imitando una capra, tra le allegre risate dei piccoli novizi. Il nome del monaco è Champa (pron. Ciampa, in tibetano: amore) [1].
Con questo evidente omaggio al Maestro del Teatro italiano, il Maestro del Cinema apre il terzo film della sua cosiddetta “trilogia esotica”: “L’ultimo imperatore” (1987, sulla vita di Pu Yi, ultimo imperatore cinese), “Il tè nel deserto” (1990, girato in Marocco da un romanzo di Paul Bowles) e “Piccolo Buddha” (1993, girato in Nepal, Buthan e Stati Uniti) [2].
Due film al prezzo di uno
1993. “Piccolo Buddha”, il famoso film di Bernardo Bertolucci, inizia con la sequenza di un giovane monaco che, alla richiesta di Lama Norbu di “mostrare qualcosa della sua vita precedente”, si mette a belare imitando una capra, tra le allegre risate dei piccoli novizi. Il nome del monaco è Champa (pron. Ciampa, in tibetano: amore) [1].
Con questo evidente omaggio al Maestro del Teatro italiano, il Maestro del Cinema apre il terzo film della sua cosiddetta “trilogia esotica”: “L’ultimo imperatore” (1987, sulla vita di Pu Yi, ultimo imperatore cinese), “Il tè nel deserto” (1990, girato in Marocco da un romanzo di Paul Bowles) e “Piccolo Buddha” (1993, girato in Nepal, Buthan e Stati Uniti) [2].
Due film al prezzo di uno
- la vicenda della ricerca della “reincarnazione” di Lama Dorje da parte del suo discepolo Lama Norbu [3], ispirata alla storia del bambino spagnolo Osel Torres, riconosciuto nel 1987 come “reincarnazione” di Lama Yeshe (morto a Los Angeles nel 1984) [4];
- la storia della vita di Siddhartha Gautama Sakyamuni, il Buddha, dal concepimento al momento del Risveglio, narrata da Bertolucci sulla base del Buddhacarita di Aśvaghoşa, classico testo mahayana del I sec. d.C. [5].
La vita del principe Siddhartha è riletta dal regista in modo tale da poter essere abilmente inserita nella vicenda della ricerca del tülku [6] di Lama Dorje, ma come vedremo questo avviene sovente a discapito della fedeltà non tanto alla lettera del testo di Aśvaghoşa, quanto piuttosto (e questo è grave, visti gli intendimenti “didattici” del film [7]) ai fondamenti degli insegnamenti del Buddha [8], che passano anche attraverso il rigore dell’iconografia e della biografia buddhiste.
Due film in uno, si è detto, e due tonalità di colore, una per film, secondo la magistrale interpretazione cromatica del direttore di fotografia, Vittorio Storaro (“Ultimo tango a Parigi”, “Novecento”, “Apocalypse Now”,…). Colori “caldi”, giallo, oro, ocra, per la vita del Buddha e per le riprese “esotiche”. Colori “freddi”, blu elettrico, toni di grigio, per le sequenze “occidentali” (un Occidente ingrigito, spento, vecchio?), girate a Seattle. Laddove giungono, seguendo gli “indizi” che Lama Dorje ha disseminato, Lama Norbu e il giovane monaco Champa.
- la storia della vita di Siddhartha Gautama Sakyamuni, il Buddha, dal concepimento al momento del Risveglio, narrata da Bertolucci sulla base del Buddhacarita di Aśvaghoşa, classico testo mahayana del I sec. d.C. [5].
La vita del principe Siddhartha è riletta dal regista in modo tale da poter essere abilmente inserita nella vicenda della ricerca del tülku [6] di Lama Dorje, ma come vedremo questo avviene sovente a discapito della fedeltà non tanto alla lettera del testo di Aśvaghoşa, quanto piuttosto (e questo è grave, visti gli intendimenti “didattici” del film [7]) ai fondamenti degli insegnamenti del Buddha [8], che passano anche attraverso il rigore dell’iconografia e della biografia buddhiste.
Due film in uno, si è detto, e due tonalità di colore, una per film, secondo la magistrale interpretazione cromatica del direttore di fotografia, Vittorio Storaro (“Ultimo tango a Parigi”, “Novecento”, “Apocalypse Now”,…). Colori “caldi”, giallo, oro, ocra, per la vita del Buddha e per le riprese “esotiche”. Colori “freddi”, blu elettrico, toni di grigio, per le sequenze “occidentali” (un Occidente ingrigito, spento, vecchio?), girate a Seattle. Laddove giungono, seguendo gli “indizi” che Lama Dorje ha disseminato, Lama Norbu e il giovane monaco Champa.
Lì incontrano i coniugi Konrad e il loro piccolo Jesse, possibile “reincarnazione” (il termine è usato e abusato nel film, nonché nella vulgata buddhista diffusa in Occidente) di Lama Dorje. Mentre Jesse legge (soprattutto ascolta) affascinato la storia del Buddha ricevuta in regalo, i suoi genitori [9] sono naturalmente pieni di dubbi e timori. Sarà un momento di grande sofferenza, la morte di un socio ed amico del padre, a sciogliere il dilemma. E mentre Siddharta abbandona la reggia paterna, è proprio il padre di Jesse, non la madre, ad accompagnare il figlio in Oriente per verificare l’identificazione, in “concorrenza” con altri due bambini, il nepalese Raju [10] e l’indiana Gita. Lì finalmente le due storie confluiscono l’una nell’altra, Siddharta “diviene” il Buddha sotto gli occhi dei tre bambini, Hollywood e Bolliwood [11] si identificano. E’ – ancora! – l’happy end: i bambini vengono riconosciuti, tutti e tre, come “reincarnazioni” di Lama Dorje, Oriente e Occidente sono riappacificati; Siddharta/Keanu Reeves ci guarda – e si fa guardare – col sorriso di un Buddha troppo compiaciuto per essere tale; e perfino Mara riesce a farci tenerezza, un po’ come la Creatura del Dr. Frankenstein, o King Kong, o il Mostro della Laguna Nera…
Un Buddha piccolo piccolo
L’attuale Dalai Lama ha espresso in termini di speranza quello che per Bernardo Bertolucci è stato l’intendimento che lo ha spinto a realizzare il suo film: “Spero quindi – ha detto Tenzin Gyatso – che film del genere contribuiscano alla comprensione dell’insegnamento buddhista per coloro che praticano culture e religioni differenti”. Lo stesso regista ha affermato che “c’è nella nostra società, oggi abiettamente consumistica, un gran bisogno di spiritualismo” [12]. E’ quindi più che verosimile che la motivazione sincera della scelta di Bertolucci di dare vita alla sua opera fosse “far conoscere e apprezzare il buddhismo” [13] ad un pubblico, quello occidentale, che “ha sempre nutrito [per esso] una certa fascinazione, ma che non è mai stato capace comunque di penetrare fino in fondo” [14].
Un Buddha piccolo piccolo
L’attuale Dalai Lama ha espresso in termini di speranza quello che per Bernardo Bertolucci è stato l’intendimento che lo ha spinto a realizzare il suo film: “Spero quindi – ha detto Tenzin Gyatso – che film del genere contribuiscano alla comprensione dell’insegnamento buddhista per coloro che praticano culture e religioni differenti”. Lo stesso regista ha affermato che “c’è nella nostra società, oggi abiettamente consumistica, un gran bisogno di spiritualismo” [12]. E’ quindi più che verosimile che la motivazione sincera della scelta di Bertolucci di dare vita alla sua opera fosse “far conoscere e apprezzare il buddhismo” [13] ad un pubblico, quello occidentale, che “ha sempre nutrito [per esso] una certa fascinazione, ma che non è mai stato capace comunque di penetrare fino in fondo” [14].

Ma se questo era il fine, quale è stato il risultato del suo sforzo, al di là dell’indubbio successo di pubblico, e anche al di là delle parole di Kundun, francamente un poco scontate?
Mauricio Yushin Marassi, monaco e missionario Soto Zen, docente universitario, è categorico: “E’ un film errato, quasi completamente fuori ruolo, addirittura negativo per l’obiettivo che il regista [..] intende perseguire” [15].
Ripercorriamo il film – e i suoi errori – seguendo la traccia lasciata dal monaco Zen nel suo breve excursus [16].
Si è detto che non è importante che Bertolucci si sia discostato dalla lettera della “biografia” del Buddha di Aśvaghoşa – mito o storia che sia. Ma, nello specifico, “dimenticare” l’ultimo dei quattro incontri del principe Siddhartha, quello con l’asceta [17] (gli altri sono con un vecchio, un malato, un morto), sacrificando la vicenda a (ipotetiche) esigenze sceniche, non significa fare opera di semplificazione, bensì oscurare il “legame [del buddhismo] con l’antica religiosità indiana” [18] ed ostacolare la comprensione del buddhismo stesso come insegnamento esperienziale, pragmatico e quindi necessariamente anti-dogmatico e non istituzionale. A favore invece di una sua interpretazione catechistica, libresca (si noti come un libro appaia all’inizio, e un altro libro costituisca il trait d’union tra il film “occidentale” e quello “orientale”). Tale interpretazione può forse essere più congeniale per un pubblico cresciuto nelle tradizioni del cristianesimo occidentale, ma è del tutto erronea.
Mauricio Yushin Marassi, monaco e missionario Soto Zen, docente universitario, è categorico: “E’ un film errato, quasi completamente fuori ruolo, addirittura negativo per l’obiettivo che il regista [..] intende perseguire” [15].
Ripercorriamo il film – e i suoi errori – seguendo la traccia lasciata dal monaco Zen nel suo breve excursus [16].
Si è detto che non è importante che Bertolucci si sia discostato dalla lettera della “biografia” del Buddha di Aśvaghoşa – mito o storia che sia. Ma, nello specifico, “dimenticare” l’ultimo dei quattro incontri del principe Siddhartha, quello con l’asceta [17] (gli altri sono con un vecchio, un malato, un morto), sacrificando la vicenda a (ipotetiche) esigenze sceniche, non significa fare opera di semplificazione, bensì oscurare il “legame [del buddhismo] con l’antica religiosità indiana” [18] ed ostacolare la comprensione del buddhismo stesso come insegnamento esperienziale, pragmatico e quindi necessariamente anti-dogmatico e non istituzionale. A favore invece di una sua interpretazione catechistica, libresca (si noti come un libro appaia all’inizio, e un altro libro costituisca il trait d’union tra il film “occidentale” e quello “orientale”). Tale interpretazione può forse essere più congeniale per un pubblico cresciuto nelle tradizioni del cristianesimo occidentale, ma è del tutto erronea.

La stessa cosa accade con la sequenza in cui Siddhartha, ancora immerso nella via dell’estremo ascetismo, ascolta le parole del musicista sulla corda troppo tesa o troppo allentata. Nell’intendimento – anzi, nel fra/intendimento – di Bertolucci, a partire di qui si dovrebbe comprendere che la corretta via sta nel mezzo. Ma in quest’ottica la Via del Buddha come Via del Mezzo altro non sarebbe che una sorta di aurea mediocritas, una filosofia del buonsenso e della moderazione: il che può forse ricordare la moderata felicità, la moderata attività, il moderato governo ecc. di Shangri-La in “Orizzonte perduto”, ma certo non i rigorosi insegnamenti del Buddha e di Maestri come Nagarjuna (la Via del Mezzo come ciò che va al di là degli estremi, non ciò che accetta un po’ dell’uno e un po’ dell’altro).
Di qui si giunge al cuore della Dottrina, ed anche della questione della sua mancata comprensione da parte di Bertolucci, nonostante le consulenze ricevute in corso d’opera. Con la ovvia conseguenza di quanto il suo film – anche perché molto ben costruito – possa aver contribuito a diffondere nel pubblico occidentale un’immagine quanto meno distorta del buddhismo. Il punto cruciale è il tema della vacuità (sunyata in sanscrito, ku in giapponese), direttamente legato alla fin troppo nominata “reincarnazione”. L’insistenza nell’uso del termine “reincarnazione”, dice M.Y. Marassi, squalifica “definitivamente ogni velleità di tipo didattico”, in quanto esso è “completamente incongruo in qualsiasi buddhismo che non sia impastato di credenze sciamaniche, dal momento che l’insegnamento base del Buddha verte sulla natura vuota di ogni cosa e di ogni esistenza, dove anche la parte sottile dell’uomo, la mente e lo spirito, sono assemblaggi di elementi che si separano disgregandosi alla nostra morte” [19]. Similmente si esprime A. Izzi: nel corso del film sarà Lama Norbu “a rimarcare come il corpo sia transeunte mentre l’anima sola permane eterna nel ciclo delle reincarnazioni andando con questo a reiterare un ennesimo fraintendimento del pensiero buddhista” [20].
Inoltre, non emerge affatto dal film una semplice realtà storica: che il metodo della ricerca dei tülku è specifico dell’area tibetano-mongolica e non appartiene né al buddhismo delle origini né alle tradizioni sino-giapponesi o del sud-est asiatico. Anche nello stesso Tibet questa tradizione ebbe inizio nel XII sec. e si affermò soltanto a partire dal XIV sec. [21].
Risultato di questi.… errori? licenze poetiche? esigenze sceniche o di botteghino (karma e reincarnazione sono molto trendy)? – è che certamente sono stati resi appetibili ad un vasto pubblico i temi magistralmente proposti nel film, ma che cosa è stato proposto da Bertolucci se non una ennesima ribollita new-age in salsa tibetana di elementi buddhisti, cristiani (c’è molto San Francesco nel suo Siddhartha), perfino hindu e, naturalmente, hollywoodiani? Condizionato in questo – come ha notato il critico cinematografico Tullio Kezich – “da quella particolare forma della cinereligione che ha per fondatore Dysney e per profeta Spielberg” [22]. E proprio sul tema cinema/religione M.Y. Marassi chiude la sua argomentazione: “dal punto di vista religioso raramente ho visto un film peggiore, completamente privo dell’alludere discreto e preciso, dell’umiltà di chi pur sapendo di non sapere si accinge a mostrare” [23].
 |
| Keanu Reeves/Siddhartha |
Inoltre, non emerge affatto dal film una semplice realtà storica: che il metodo della ricerca dei tülku è specifico dell’area tibetano-mongolica e non appartiene né al buddhismo delle origini né alle tradizioni sino-giapponesi o del sud-est asiatico. Anche nello stesso Tibet questa tradizione ebbe inizio nel XII sec. e si affermò soltanto a partire dal XIV sec. [21].
Risultato di questi.… errori? licenze poetiche? esigenze sceniche o di botteghino (karma e reincarnazione sono molto trendy)? – è che certamente sono stati resi appetibili ad un vasto pubblico i temi magistralmente proposti nel film, ma che cosa è stato proposto da Bertolucci se non una ennesima ribollita new-age in salsa tibetana di elementi buddhisti, cristiani (c’è molto San Francesco nel suo Siddhartha), perfino hindu e, naturalmente, hollywoodiani? Condizionato in questo – come ha notato il critico cinematografico Tullio Kezich – “da quella particolare forma della cinereligione che ha per fondatore Dysney e per profeta Spielberg” [22]. E proprio sul tema cinema/religione M.Y. Marassi chiude la sua argomentazione: “dal punto di vista religioso raramente ho visto un film peggiore, completamente privo dell’alludere discreto e preciso, dell’umiltà di chi pur sapendo di non sapere si accinge a mostrare” [23].
Per concludere, può essere interessante proporre – per una riflessione personale sui temi della vacuità e dell’impermanenza – alcuni passi tratti dal Mahāparinibbānasuttanta, il Sutra del Nirvana definitivo. All’estinzione del Buddha, Sakka, re degli dèi, disse: “Impermanenti sono i sáņkhāra [24], elementi sorgenti a danno. Distrutto ciò che mena a rinascere [25], il loro estinguersi è gioia”. E il discepolo Anuruddha, rivolto ai monaci in lacrime: “Orsù, o amici, non piangete, non lamentatevi. Non fu forse, o amici, dal Sublime in precedenza detto che di tutte le cose piacevoli e gradevoli è naturale il mutare, è naturale il separarsi, è naturale il diversificarsi? [..] Che ciò che è nato, divenuto, nominabile, elemento dissolubile, non venga dissolto, tale possibilità non si conosce” [26].
NOTE
1. Ad abundantiam, si osservi che il ruolo di Maria, la governante di casa Konrad, è interpretato dall’attrice italo-americana Jo Champa…
2. Altri famosi film di Bertolucci, figlio del poeta Attilio, sono: “Ultimo tango a Parigi”, “Novecento”, “La luna”, “Io ballo da sola”… Del “Piccolo Buddha” Bertolucci è anche soggettista e sceneggiatore.
3. Interpretato da Ruocheng Ying, attore cinese già visto ne “L’ultimo imperatore”.
4.Si legga a questo proposito Reincarnazione. Il piccolo grande Lama di Vickie Mackenzie, pubblicato dalle Ed. Chiara Luce nel 1992, l’anno prima del film. Alla vicenda è stato dedicato uno degli incontri di questo corso nel 2006.
5. Pubblicato in Italia dall’Ed. Adelphi con il titolo: Le gesta del Buddha.
6. Il termine tülku indica nella tradizione tibetana la manifestazione in forma fisica di un Buddha, o di un essere progredito che si basa sulle proprie realizzazioni per “pilotare” il processo post mortem e le circostanze della rinascita del continuum psichico, sempre per aiutare gli esseri senzienti. Quindi non è una “persona” che si reincarna, ma la mente di saggezza di un maestro defunto (da: Ph. Cornu, Dizionario del Buddhismo, Ed. Bruno Mondadori, alla voce tülku).
7. “Bertolucci assume nei confronti dello spettatore occidentale una precisa [..] vocazione didattica” (A. Izzi, Dal Tibet a Hollywood. Bertolucci, Scorsese e Herzog: tre sguardi occidentali sul buddhismo, Ed. Aracne, pag.47)
8. Primo tra tutti la vacuità, ovvero l’assenza di esistenza intrinseca dei fenomeni.
9. La figura della madre è interpretata da Bridget Fonda, figlia di Peter (un titolo per tutti: “Easy Rider”) e nipote del nonno Henry e della zia Jane – ed è Storia del cinema..…
10. Attualmente l’attore che interpretò Raju, Raju Lal, ha più di 20 anni, vive nei ghetti accanto alla stazione di New Delhi, è tuttora analfabeta e fa il lustrascarpe (da L. Zerbetto, Fa il lustrascarpe a Nuova Delhi…, in: www.santantonio.org/messaggero/pagina_stampa.asp?R=&ID=1049).11. Col termine “Bollywood” (Hollywood + Bombay) si intende il cinema popolare indiano. L’industria cinematografica indiana è la più grande del mondo, Bombay (oggi Mumbai) è una delle sue maggiori sedi. In India viene prodotto un numero di film che è quasi il doppio di quelli prodotti negli USA.
12. Il Corriere della Sera, 16 maggio 1996.
13. Mauricio Yushin Marassi, scheda cinematografica in: Cinema e Buddismo, a cura di G. Martini, Ed. Centro Ambrosiano, pag. 69 (di qui in poi citato come MYM).
14. A. Izzi, Dal Tibet a Hollywood, pag. 49.
15. MYM, pag. 69.
16. Leggibile anche sul sito www.lastelladelmattino.org/buddista/
17. “Io sono un asceta che terrorizzato da nascita e da morte ha abbandonato [il mondo] per la Liberazione. In un mondo in cui la distruzione è legge, io, volendo essere libero, cerco lo stato beato e indistruttibile rimanendo equanime verso parenti ed estranei assieme e avverso a passione o odio per gli oggetti dei sensi” (Le gesta del Buddha, canto V, 17-18).
18. MYM, pag. 69.
19. MYM, pag. 69.
20. A. Izzi, Dal Tibet a Hollywood, pag. 48-49.
21. Si veda a questo proposito il I volume de Il buddhismo mahayana attraverso i luoghi, i tempi e le culture di M.Y. Marassi, Ed. Marietti.
22. T. Kezich, Il piccolo Buddha o la Fiaba infinita, in: Corriere della Sera, 10 dicembre 1993.
23. MYM, pag 69. Certo, se si parla di pessimi film sul tema “religione” e si pensa a “Fratello Sole Sorella Luna” di Zeffirelli…..
24. Sono le formazioni mentali della volizione, la cui natura è costruire la nostra visione dell’esistenza. Tale visione è condizionata dagli elementi del passato e determina gli aggregati dell’esistenza futura (da: Ph. Cornu, Dizionario del Buddhismo, alla voce: formazioni karmiche).
25. Si noti, si parla di “rinascita”, non di “reincarnazione”.
26. Il Grande Dialogo del Nirvana Definitivo, Ed. TEA, pagg. 122-123.
m. mauro tonko, marzo 2009